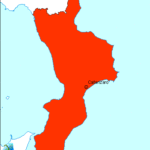 In un interessante saggio pubblicato nel 2016 da Barone, David e De Blasio (“Boulevard of broken dreams. The end of EU funding”) si dimostra che nel periodo successivo all’uscita dal club delle regioni dell’Obiettivo 1, il PIL pro-capite degli abruzzesi cresce debolmente e meno di quanto si sarebbe osservato se l’Abruzzo avesse mantenuto il pre-esistente status. In altre parole, la ricchezza dei residenti in Abruzzo non mostra una dinamica di crescita auto-sostenuta. Si tratta di una valutazione che aiuta a capire la relazione tra fondi strutturali e crescita economica. Occorre dire che questa conclusione non è limitata al caso abruzzese ma, al contrario, è simile, nella sostanza delle cose, a quella cui pervengono numerosi altri studi che analizzano l’impatto dei fondi sui processi di convergenza economica tra le regioni europee o tra quelle di singoli stati membri. La sintesi di questa letteratura è che i fondi della politica regionale dell’UE hanno un mero effetto ridistributivo e non intaccano le condizioni di offerta di chi ne beneficia. In altre parole, in moltissime regioni i fondi comunitari sono inefficaci in termini di cambiamento delle caratteristiche produttive che condizionano i sentieri di transizione verso la crescita di lungo periodo. Il che è molto contro-intuitivo perché la principale motivazione della loro esistenza è di stimolare lo sradicamento dei vincoli e di colmare i deficit strutturali delle regioni beneficiarie al fine di avviarle verso lo sviluppo autonomo e indipendente dai regimi di aiuto.
In un interessante saggio pubblicato nel 2016 da Barone, David e De Blasio (“Boulevard of broken dreams. The end of EU funding”) si dimostra che nel periodo successivo all’uscita dal club delle regioni dell’Obiettivo 1, il PIL pro-capite degli abruzzesi cresce debolmente e meno di quanto si sarebbe osservato se l’Abruzzo avesse mantenuto il pre-esistente status. In altre parole, la ricchezza dei residenti in Abruzzo non mostra una dinamica di crescita auto-sostenuta. Si tratta di una valutazione che aiuta a capire la relazione tra fondi strutturali e crescita economica. Occorre dire che questa conclusione non è limitata al caso abruzzese ma, al contrario, è simile, nella sostanza delle cose, a quella cui pervengono numerosi altri studi che analizzano l’impatto dei fondi sui processi di convergenza economica tra le regioni europee o tra quelle di singoli stati membri. La sintesi di questa letteratura è che i fondi della politica regionale dell’UE hanno un mero effetto ridistributivo e non intaccano le condizioni di offerta di chi ne beneficia. In altre parole, in moltissime regioni i fondi comunitari sono inefficaci in termini di cambiamento delle caratteristiche produttive che condizionano i sentieri di transizione verso la crescita di lungo periodo. Il che è molto contro-intuitivo perché la principale motivazione della loro esistenza è di stimolare lo sradicamento dei vincoli e di colmare i deficit strutturali delle regioni beneficiarie al fine di avviarle verso lo sviluppo autonomo e indipendente dai regimi di aiuto.
Se da un lato è chiaro che queste politiche funzionano bene in termini ridistributivi, dall’altro lato appare utile formulare una riflessione su quanto debbano durare. Quanto deve durare il regime di aiuto? Si fa riferimento esplicito ai fondi strutturali, ma le stesse argomentazioni possono essere estese a qualsiasi intervento pubblico (nazionale e comunitario) di cui sono beneficiarie le regioni del Mezzogiorno d’Italia. L’opinione di chi scrive è che l’aiuto debba essere temporaneo e non duraturo, in quanto è poco verosimile immaginare che qualcuno finanzi lo sviluppo regionale in un orizzonte temporale infinito. Peraltro, molta letteratura economica dimostra in modo inequivocabile che la persistenza dell’assistenza esterna crea distorsioni che frenano l’efficiente funzionamento dei mercati. Ciò detto, è banale ribadire che i vantaggi degli aiuti debbano essere massimizzati nella fase di implementazione delle politiche, al fine di consentire alle regioni di poter camminare da sole nei periodi successivi. Se gli investimenti dei fondi strutturali fossero finalizzati a rimuovere le cause del sottosviluppo e capaci di innescare virtuosi meccanismi di crescita, i sistemi economici regionali ne trarrebbero dei vantaggi in modo permanente. Nella realtà si osserva, invece, che la spinta esercitata da questi fondi è limitata al periodo della loro implementazione ed è semplicemente legata all’erogazione delle risorse che essi mobilitano in ogni ciclo di programmazione. Un caso emblematico riguarda la Calabria: la chiusura del ciclo 2007-2013 ha determinato un’accelerazione della certificazione delle spese nel 2015 e questo ha alimentato di qualche decimale l’incremento (attorno all’1%) del PIL regionale osservato nel 2015 rispetto al 2014. In generale, possiamo dire che il consumo è la componente della domanda aggregata più sollecitata da queste politiche. È chiaro che si hanno dei benefici se si partecipa ad un bando, poiché si ricevono risorse (“effetto ridistributivo”) per i progetti finanziati, ma se le attività e gli investimenti che si realizzano sono, in media, inutili, è altrettanto chiaro che al termine del progetto tutto ritorna allo stato iniziale. L’occupazione e gli investimenti sono temporanei: tutti a casa dopo il progetto. In rarissimi casi c’è continuità delle attività. Questo circolo vizioso di spesa che alimenta consumo o finanzia in via temporanea pessimi investimenti, caratterizza lo stato di attuazione delle politiche comunitarie in Calabria: contrariamente agli sforzi narrativi della copiosa documentazione regionale, è evidente che si tratta di politiche del tutto inutili in termini di impatto sullo sviluppo di medio-lungo periodo dell’economia regionale.
Se il meccanismo ridistributivo funziona bene – abbiamo visto che la dinamica del PIL pro-capite è fortemente dipendente dalla presenza della spesa comunitaria – appare importante capire che cosa potrà succedere in prospettiva. Un primo scenario è che riceveremo persistentemente sostegno esterno: esisterà sempre e comunque una massa di aiuti che alimenterà le componenti a più basso impatto sistemico della domanda aggregata: il consumo, in particolare di beni importati – e gli investimenti pubblici e privati di bassa qualità. E’ un’ipotesi che perfino i più accaniti sostenitori delle politiche comunitarie (tutto l’entourage della filiera istituzionale incollata ai fondi strutturali da Bruxelles alle periferie e qualche economista) ritengono essere inverosimile e non auspicabile. Da un lato perché la finanza pubblica è soggetta a restrizioni sia sui livelli sia (finalmente) sulla qualità della spesa. Dall’altro lato, nessuno potrebbe argomentare che trattasi di cosa buona avere un’economia che dipende in modo perpetuo da infruttuosi capitali pubblici. Il secondo scenario è che riceveremo meno risorse comunitarie. Si tratta di un’ipotesi che potrebbe verificarsi qualora dovessero concretizzarsi le proposte relative (i) alla centralizzazione (ii) al ridimensionamento della politica di coesione nel bilancio comunitario e (ii) al cambiamento dei criteri di assegnazione delle risorse agli stati membri. Che cosa faremo, quindi, con meno (o senza) fondi comunitari? Forse sarebbe una buona occasione per pensare ad un modello di sviluppo in cui inizi a contare di più il dinamismo dei privati, piuttosto che assistere a duraturi sperperi di risorse pubbliche.
[starbox id=3]
*Questo saggio è stato pubblicato sul Quotidiano del Sud (Edizione del 21 Giugno 2017)



